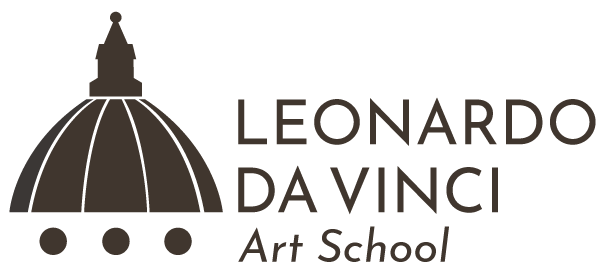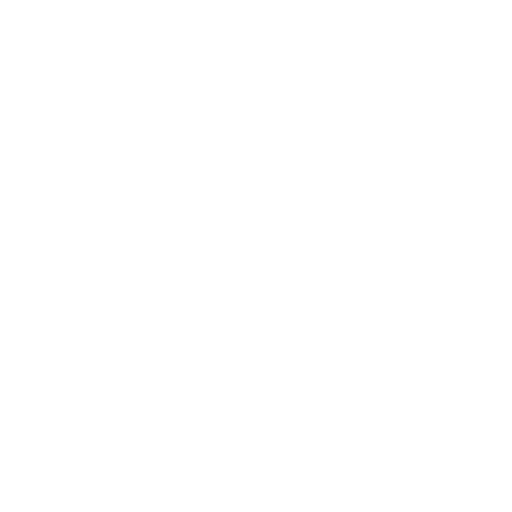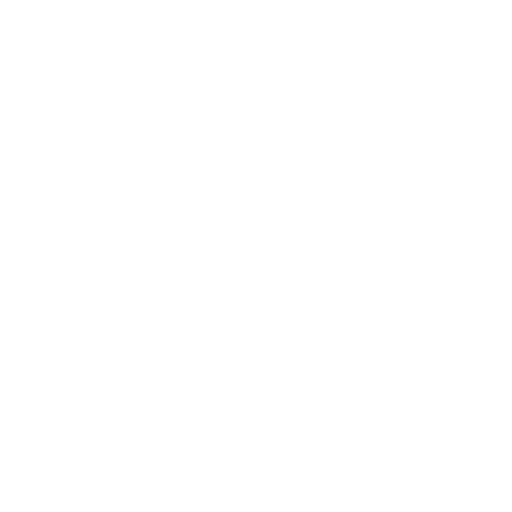Oltre il Rinascimento a Firenze – Il Nuovo Palazzo di Giustizia. L’inizio della storia
Il Nuovo Palazzo di Giustizia è l’opera più impegnativa,
spettacolare e interessante degli ultimi decenni. E naturalmente è stato fonte
di infinite polemiche, come tutto a Firenze.
L’esigenza di riunire le funzioni giudiziarie risale
addirittura al 1867, ai tempi di Firenze Capitale (1865 – 1870). In attesa di
costruire una “cittadella della giustizia”,
per decenni gli uffici vengono distribuiti “provvisoriamente”
in molti palazzi diversi, spesso lontani tra loro. Continuamente vengono
costituite commissioni di esperti che propongono l’utilizzazione di vari
palazzi del centro, ma nessun vero progetto viene realizzato. Nel 1964 il
Comune prende in considerazione l’idea di demolire il vecchio Parterre in
Piazza della Libertà, costruito nel 1937 come Palazzo delle Esposizioni
sull’area di un giardino alla francese (parterres)
costruito dal Granduca Pietro Leopoldo fuori dalla mura, davanti all’Arco di
Trionfo dei Lorena. Ma nel 1974 una commissione istituita dal Comune cambia
ancora una volta idea e decide per l’area periferica degli ex-Macelli (il
vecchio mattatoio). Nel 1976 viene individuata un’altra area a Peretola, un
sobborgo, all’epoca decisamente fuori città. Con la decisione della Fiat di
trasferirsi a Campi Bisenzio, la grande area tra via di Novoli e viale Guidoni
nel 1982 viene presa in considerazione.
Questi continui cambiamenti nascondono spesso manovre
clientelari, politiche e addirittura elettorali, in quanto un’opera del genere
avrebbe mosso grandi investimenti, molto denaro, interessi aziendali, appalti,
consulenze, commesse e posti di lavoro.
Finalmente nel 1987 si decide per l’area ex-Fiat e il
progetto viene assegnato a Giovanni Michelucci e a Leonardo Ricci, i due
architetti toscani più rappresentativi dell’epoca. Ricci ha già l’esperienza del
Palazzo di Giustizia di Savona, realizzato in quegli anni, che anticipa lo
stile e molti elementi strutturali del palazzo di Firenze. In particolare i
materiali, la grande vetrata obliqua addossata a corpi sporgenti, la finestra
circolare simile a un rosone da chiesa, il “brutalismo”
del cemento grezzo a vista. E anche le infinite polemiche che lo hanno
accompagnato.
I due architetti collaborano fino al 1987 con i primi disegni
e stabiliscono le idee di base. Ma poi Michelucci si ritira, ufficialmente per
disaccordi con la committenza. Quali disaccordi? Michelucci si rende conto di
non volere un edificio centralizzato in periferia per tutti i servizi
giudiziari, come richiesto dal Ministero Italiano della Giustizia. Vede l’idea
di spostare così tante funzioni civili dal centro storico e isolare la “città della giustizia” in periferia come
uno snaturamento, una rottura con la storia e con il ruolo sociale dei centri
storici. È poco convinto della possibilità di collegare il nuovo
edificio con l’identità della città. Teme che rimanga un’isola separata, una
cittadella sentita come “altro, lontano e
alla fine ostile”. Teorizza quindi di utilizzare spazi disseminati
all’interno del centro storico, riadattandoli e ristrutturandoli. Continua a
vedere il centro come protagonista, è legato all’idea di Filippo Brunelleschi,
la Cupola del Duomo come riferimento della vita sociale e civile, perno su cui
tutta la città converge, anche le periferie e le colline, e che determina la
sua identità.
Da meditare la seguente affermazione profetica di Michelucci,
considerando che è uno dei maggiori architetti italiani del XX secolo: “A mio parere però non è la periferia che ha
cambiato la città, semmai l’ha cristallizzata; una città cioè che non è in
grado di sviluppare le sue caratteristiche, fatalmente è costretta a vedersi
circondata, aggredita dal diverso da sé, per cui il concetto di identità si
restringe a pochissimi monumenti, e tutto il resto non appare come sviluppo di
un organismo che naturalmente nasce, cresce e muore, ma come metastasi prodotte
da potenze oscure”.
Il secondo motivo del suo disaccordo è il “vuoto di committenza”, cioè la poca
chiarezza dell’immagine che la giustizia
vuole dare di sé e che Michelucci vorrebbe riflessa nella costruzione. Sono gli
anni ’80 e il paese si sta trasformando velocemente, ma in modo confuso e senza
sapere chiaramente dove sta andando. Michelucci percepisce questa confusione e
constata che il committente, il Ministero della Giustizia e la classe politica
del tempo, non è in grado di chiarire l’immagine da dare agli edifici
giudiziari, quello che per l’architetto razionalista costituisce il “senso” dell’opera. Gli uffici mandano
continuamente piani, relazioni contraddittorie, funzioni nuove, percorsi
aggiuntivi, varianti, schemi sempre diversi spesso in contrasto tra loro,
dimostrando chiaramente di non avere le idee chiare. In queste condizioni si
dichiara incapace di operare, non riesce ad avere una visione.
Continua …

Il lato est, praticamente il retro del palazzo

Veduta da sud-est dal laghetto di San Donato