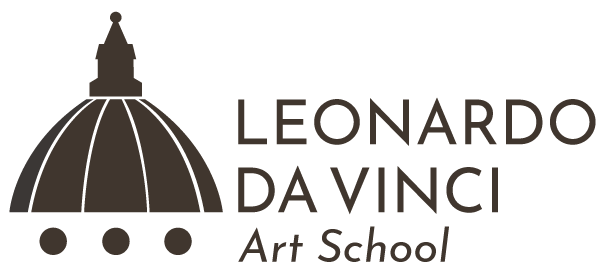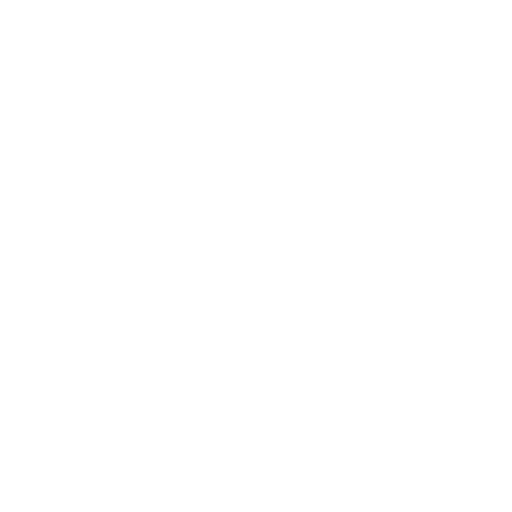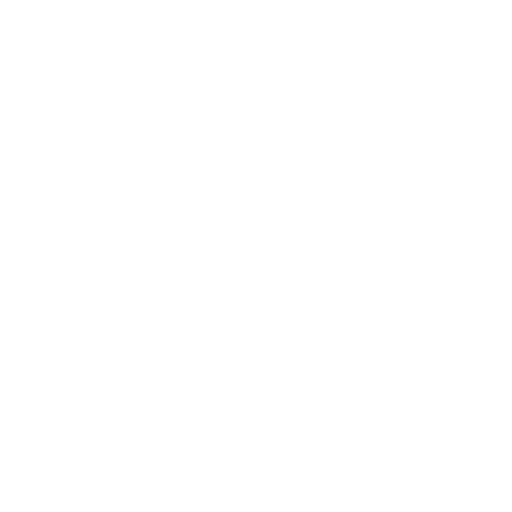I giardini di Firenze – Il Parco della Rimembranza di San Miniato a Monte
Il cipresso (Cupressus Sempervirens) fa parte da millenni del paesaggio toscano, in particolare nelle province di Firenze e Siena, insieme all’olivo e alla vite. Originario dell’Iran, si è diffuso nel Mediterraneo perché ama il clima caldo e secco. Molto resistente, può vivere migliaia di anni. Fin dall’antichità è associato ai cimiteri e ai viali perché le sue radici scendono dritte in profondità invece che in orizzontale come quelle di altri alberi, senza disturbare ciò che li circonda, e questo lo rende l'albero perfetto da piantare nelle vicinanze di sepolture o strade.
Purtroppo il cipresso combatte da molto tempo
contro una malattia chiamata Cancro da Corineo (Coryneum Cardinale), un
fungo che attacca l'albero e lo secca. Questo processo viene favorito nel
momento in cui giunge il clima freddo e umido che il cipresso non gradisce, e
di conseguenza produce fessurazioni nel legno in cui il fungo si insinua. Pare
che questa malattia sia arrivata durante la guerra, nel 1944, quando l’esercito
americano portò in Europa enormi quantità di armi e munizioni dentro casse di
legno di cipresso della California, affetto proprio da Cancro da Corineo. La
Regione Toscana si sta impegnando per debellare questa malattia, con costosi
interventi fitosanitari e selezioni di alberi resistenti ai parassiti. Adesso
sembra che la situazione stia migliorando, ma c’è stato un momento quando
sembrava che il cipresso toscano fosse destinato a scomparire perché più del 50
% delle piante era ammalato.
Dietro la Chiesa di San Miniato a Monte, vi è il Parco della Rimembranza, un bosco solo di cipressi, costituito da ben 3000 piante. Si tratta di una rarità, poiché questo albero viene generalmente usato per viali, cimiteri, o piantato insieme ad altre specie. Il bosco, attraversato solo da un piccolo sentiero, ha un aspetto alquanto tetro. Poco sole penetra in questa muraglia di chiome scure, dove i cipressi sono stati piantati molto vicini l'uno a l'altro.
Questa atmosfera cupa riflette, tuttavia, il triste motivo per cui il bosco è stato creato. Tra il 1922 e il 1925, il governo fascista ordinò a tutte le amministrazioni locali, comuni e province d'Italia, di realizzare delle “selve votive”: parchi dedicati ai soldati italiani caduti durante la Prima Guerra Mondiale. In ogni comune, vennero inoltre eretti monumenti ai caduti. Il regime si occupava con grande attenzione della costruzione e pianificazione di queste strutture dall’estetica e i contenuti rigorosamente nazionalistici e militaristi. Per far loro spazio, tutte le lapidi e i monumenti già presenti, vennero distrutti.
Questa “selva votiva” fiorentina, con i suoi 3000 cipressi dedicati ad altrettanti fiorentini deceduti in guerra, venne inaugurata nel 1927. Al suo interno vennero posti due monumenti ai caduti, realizzati da Angelo Vannetti. Il primo, all’inizio del sentiero, è un altare di pietra serena - la pietra del Rinascimento - con una semplice iscrizione: “La vostra tomba è un’ara”. Il secondo, realizzato in bronzo secondo le linee guida del governo, è visibile solo da chi si avventura nel fitto del bosco: il “Fante all’attacco”, in posa guerresca, con un’espressione feroce e con la baionetta innestata.
Angiolo
Vannetti (1881 – 1962) era un artista livornese che lavorò molto all’estero e
nelle colonie italiane, e questa sua opera presenta dettagli con un grande valore
artistico, non frequenti in questo tipo di monumenti. In particolare,
l’ingombrante cappotto militare sbottonato che avvolge il corpo del
fante, è realizzato con considerevole abilità e realismo. Il gioco delle pieghe
del tessuto, di cui si percepisce la pesantezza, oltre a fornire un notevole
effetto plastico, contribuisce a dare dinamicità all’intera figura.
Questo monumento è da anni in stato di abbandono, vandalizzato, ricoperto di
escrementi di piccione, la baionetta è stata rubata, sul volto scurito dal
tempo a stento si intravedono dei lineamenti umani.
Il degrado e l'aspetto miserabile di questo povero fante, ne hanno trasformato
in qualche modo il messaggio. Morta la retorica nazionalista, è diventato un triste
monumento alle migliaia di poveri disgraziati, strappati alla loro vita e
gettati nell’inferno di una guerra di cui capivano a stento le ragioni. Per di
più, ora evidentemente dimenticati e umiliati con atti di vandalismo. Le
perdite italiane nella Prima Guerra Mondiale furono 650.000 morti e 1.000.000
invalidi e mutilati.
Se venite in questo luogo durante un nebbioso giorno invernale, ad incontrare
quelle 3000 anime, vi sembrerà quasi di entrare
nella “selva oscura” della Divina Commedia di Dante Alighieri:
Nel
mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
ché la diritta via era smarrita.
Ahi
quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!

Il "fante all'assalto" e l'Ara votiva