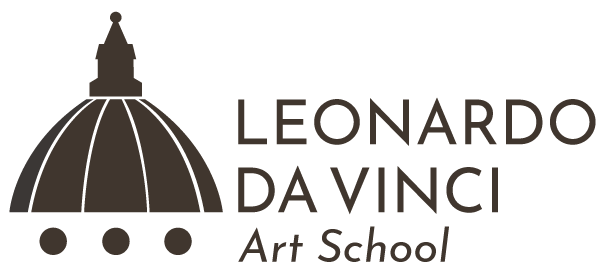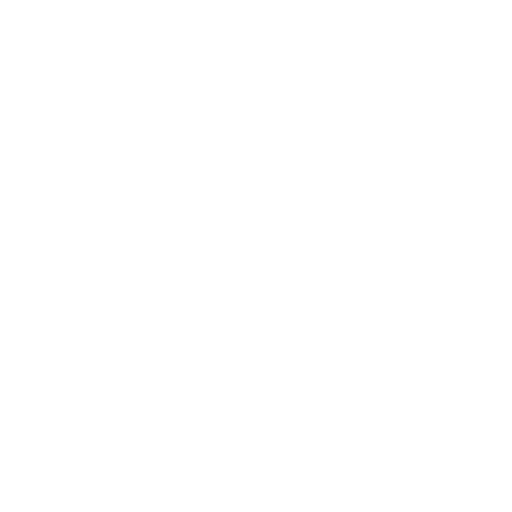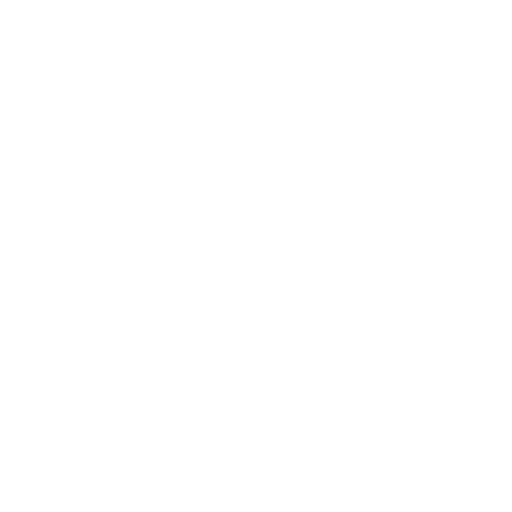Oltre il Rinascimento a Firenze - La Manifattura Tabacchi di Firenze e l’emancipazione femminile
La Manifattura Tabacchi: un quartiere di 16
edifici su un’area di 100.000 mq, accanto al Parco delle Cascine. Pura
architettura razionalista modernista, progettata dagli architetti Giovanni
Bartoli e Pier Luigi Nervi nel 1933, completata nel 1940. Secondo i canoni
architettonici modernisti, la struttura doveva essere funzionale all’uso a cui
era destinata, e tutto doveva essere subordinato a questo obiettivo. Canone
estetico: è bello ciò che è funzionale, l’eleganza è legata solo alla scelta
dei materiali e alla chiarezza geometrica e strutturale. Questi edifici
rispondono a questi principi e vengono lodati dalla critica per l’equilibrio,
la linearità architettonica e il dinamismo spaziale. Come pietra di
rivestimento fu utilizzato il travertino, una pietra sedimentaria chiara, porosa
e leggera, molto usata a Roma (p.e. Colosseo, Piazza San Pietro), pochissimo a
Firenze.
Particolarmente interessante all’interno l’Edificio
dell’Orologio, con grandi vetrate a nastro in
vetrocemento che lasciano intravedere le scale. Una dichiarazione di funzionalismo. Ospitava la direzione e gli
uffici amministrativi. Ai lati delle porta la scritta "Anno XV EF", quindicesimo
anno dell’Era Fascista, cioè 1937. I fascisti contavano gli anni dal 1922, data
della Marcia su Roma e presa del potere.
All’esterno l’attuale Teatro Puccini, oggi una
istituzione culturale d’avanguardia, che chiude l’angolo a nord-est del
complesso. All’epoca della costruzione costituiva la sede del Dopolavoro per i
dipendenti della manifattura e le loro famiglie. Il Fascismo infatti promuoveva
queste attività culturali e ricreative, essenzialmente per motivi di propaganda
e controllo politico. È costituito da un esterno lineare e da una struttura interna teatrale molto moderna. L’appariscente torre rivestita di pannelli in
vetrocemento, come quelli dell’Edificio dell’Orologio, è una copia della Torre
di Maratona dello Stadio Comunale, progettato dallo stesso architetto Pier
Luigi Nervi. Non ha altra funzione che contenere la scala per raggiungere la
sommità, visibile quando la torre è accesa e risplende nella notte. Serviva
come elemento di monumentalità, un’insegna che viene in avanti come la prua di
una nave. Elementi di retorica fascista sono la forma della facciata che
ricorda un’aquila e il bassorilievo che rappresenta le Madri Operaie, dello scultore
Francesco Coccia, ricordato principalmente per il gruppo scultoreo davanti alle
Fosse Ardeatine a Roma.
Una grande area ex-industriale rinata a nuova
vita e destinata a molteplici attività: sede di una scuola internazionale di
moda e design, ma anche di corsi dell’Accademia Statale di Belle Arti di
Firenze. E poi: laboratori artigiani di qualità, atelier per artisti, gallerie
d’arte, spazi espositivi, Student Hotel, residenze private, aree di gioco per
bambini e infine aree per grandi eventi.
Una rottura con il passato, un passato importante per la storia della città.
La Toscana è stata tra il 1600 e il 1900 un importante centro di coltivazione
di tabacco e produzione di sigari, specialmente Firenze e Lucca. La storia del business del tabacco in Toscana inizia nel 1574, quando il
Cardinale Niccolò Tornabuoni manda dei semi di tabacco Kentucky, ricevuti
dall’America, al nipote vescovo di Sansepolcro, che a sua volta li regala al
Granduca Cosimo I dei Medici che ne intuisce il valore e ne favorisce la coltivazione.
Il sigaro
Toscano, molto forte e dal gusto particolare, ha un'origine particolare. Leggenda vuole
che nell’agosto 1815, un temporale infradiciasse una grossa quantità di tabacco.
Invece di gettarla, si decide di produrre sigari da vendere a poco prezzo. Quel che accade però, è che l’acqua produce una fermentazione che dà ai sigari un gusto nuovo e
inconfondibile. È subito un enorme successo. È nato il sigaro Toscano.
Gli addetti alla produzione dei sigari erano migliaia. Tra
le due guerre, in Italia erano 16.000, a Firenze erano 1400, quasi tutte donne. La
lavorazione era fatta tutta a mano. Le "sigaraie"
dovevano scegliere le foglie migliori e adatte alle varie lavorazioni, poi
dovevano arrotolare le foglie esterne sull’interno, una per volta. In un
giorno, a volte anche di 14 ore, facevano 500 pezzi a testa, poi controllati,
essiccati e confezionati.
Le sigaraie,
hanno avuto una funzione fondamentale nella storia della città. Hanno costituito
il primo esempio di organizzazione e emancipazione femminile, dando a migliaia
di donne indipendenza economica e dignità professionale, a quei tempi molto
difficile da ottenere. Organizzate in Leghe e solidali tra loro, le sigaraie sono state protagoniste di
lotte e scioperi memorabili. Un'avanguardia.
Nel marzo del 1944, quando il fronte
stava per raggiungere Firenze e la Manifattura, le sigaraie scioperarono per avere
più da mangiare e potere correre subito nei rifugi durante gli allarmi per i bombardamenti aerei, senza dover subire la consueta perquisizione, poichè sempre sospettate di rubare i sigari.
Anche se la Manifattura Tabacchi di Firenze ha
chiuso definitivamente il 16 marzo 2001, qualcosa di questo spirito è
rimasto nel Genius Loci del luogo,
forse il senso di comunità e solidarietà.
Lo Stato Italiano ha venduto le manifatture,
che sono state quasi tutte delocalizzate prima in Puglia, poi in Romania nel
2011. Da quella data non è stata prodotta più una sigaretta in Italia. Ma il Sigaro
Toscano, ormai un prodotto per amatori molto esportato all’estero, continua a
essere prodotto, in piccole quantità rispetto al passato, da una società italiana a Lucca e a Cava dei Tirreni, vicino a
Salerno, in fabbriche fortemente automatizzate. Voci incontrollate dicono che una
piccola parte di sigari a Lucca sia ancora prodotta a mano.
Foto di copertina: l’Edificio n° 6, detto
dell’Orologio.

L’entrata principale con i bassorilievi di Francesco
Coccia, che rappresentano le fasi della lavorazione
del tabacco. Da notare come vi siano rappresentati solo uomini, mentre il tabacco era
lavorato per il 90 % da donne.

Il Teatro Puccini, ex Dopolavoro, con la
torre vetrata.

Il bassorilievo, chiamato Le
madri operaie, ancora una volta mancante di figure femminili.