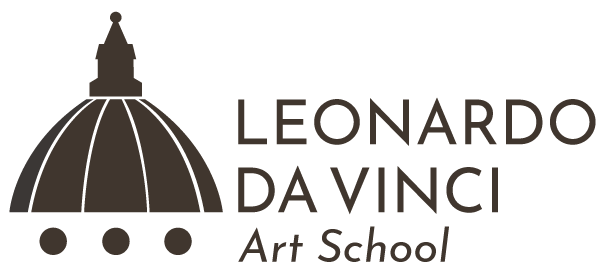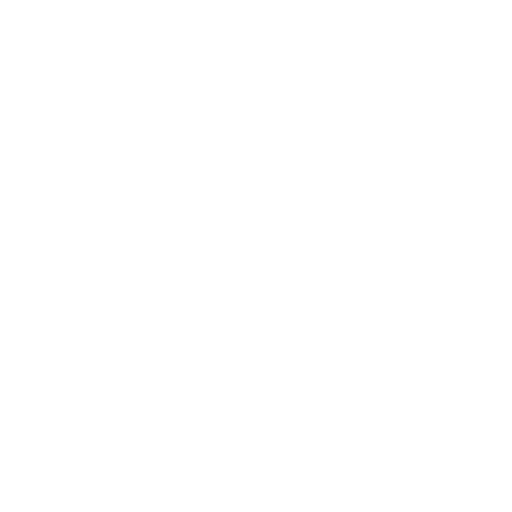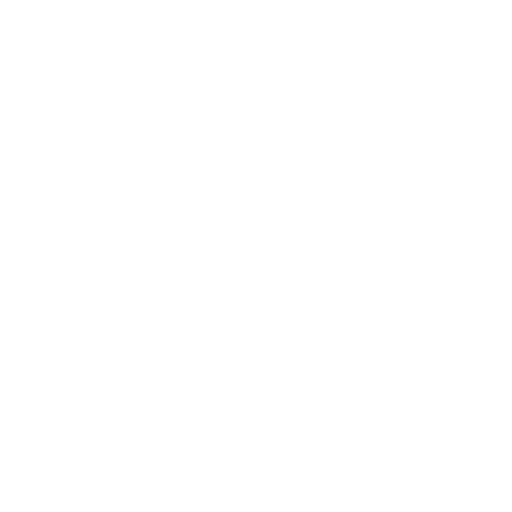I giardini di Firenze – Piazza dei Ciompi e le sue storie
Una piccola piazza nel cuore del quartiere di
Santa Croce. Apparentemente antica, in realtà nata negli anni ’30 del 1900,
quando fu deciso di demolire l’area, affollata di edifici antichi considerati malsani
e degradati, per costruire un quartiere moderno. Il fascismo per questi
interventi urbanistici usava l’espressione “il piccone risanatore”. Dai
fiorentini fu chiamato invece “lo sventramento”, un termine eloquente tratto
dalla macelleria, già usato per la distruzione del Mercato Vecchio e del Ghetto
nel 1885 per costruire Piazza della Repubblica. In quest'area di Santa Croce molti edifici risalivano al
1500 e alloggiavano botteghe di artigiani e artisti, tra cui la presunta
bottega di Cimabue, dove aveva lavorato Giotto.
I lavori nell'area di Piazza dei Ciompi, interrotti dalla guerra, si
conclusero nel 1948 con la costruzione di mediocri palazzi e, lì vicino, del molto discusso
Palazzo della Sede Provinciale della Direzione delle Poste, firmato dal grande
architetto Giovanni Michelucci. Non vogliamo entrare nella polemica infinita sul
valore architettonico di questo edificio, ma una cosa salta agli occhi di
tutti: la poco visibile integrazione nell’ambiente circostante e la discutibile
attrattiva del cemento armato grezzo a vista.
Nel 1955 sul lato nord fu riscostruita la
Loggia del Pesce, una vittima dello “sventramento” del 1885. Costruita nel
1568 nell'area del Mercato Vecchio, ora Piazza della Repubblica, per i pesciaioli, originariamente sistemati al Ponte Vecchio da dove erano stati scacciati
per costruire il Corridoio Vasariano che collegava Palazzo Pitti (abitazione
del Granduca) con Palazzo Vecchio (sede del Governo cittadino). Il nuovo passaggio sopraelevato permetteva ai
granduchi di spostarsi senza rischiare attentati, o peggio, contagi in
occasione delle frequenti epidemie. Nel 1955, il Comune, sponsorizzato dalla Cassa di Risparmio di Firenze, decise di rimontare
in Piazza dei Ciompi la Loggia del Pesce, i cui pezzi erano conservati nei magazzini del
Museo di San Marco.
Dopo essere stata per anni sede
del Marcato delle Pulci, oggi la piazza è diventata parco pubblico, con al centro un bellissimo
pino domestico di almeno 80 anni, che misura più di 20 m di altezza e altrettanti di diametro, e tutto intorno degli alberi d'arancio.
Tra gli edifici sul lato sud della piazza troviamo la casa di
Lorenzo Ghiberti (1378 – 1455), scultore, orafo, architetto e scrittore, famoso
per la Porta Dorata del Paradiso del Battistero di Firenze e le statue della
Chiesa di Orsanmichele.
Nell’edificio ha avuto sede per decenni la Casa
del Popolo Buonarroti, così nominata in onore di Michelangelo Buonarroti, che possedeva abitazioni lì vicino. Le Case del Popolo, legate ai partiti di sinistra,
erano associazioni culturali e sedi di servizi assistenziali, mutualistici e
ricreativi, ma anche di cooperative di lavoro e di consumo.
La Buonarroti è stata, dagli anni ’50 del 1900
fino agli anni ’80, uno dei centri culturali della sinistra fiorentina. Ora
è sede del Centro Studi dell’ARCI Firenze. L’ARCI (Associazione Ricreativa e
Culturale Italiana), è stata fondata nel 1957 dai partiti della sinistra ed ha avuto un ruolo
fondamentale nella storia culturale italiana del secondo dopoguerra e in
particolare di Firenze. Contiene il ricchissimo archivio di tutte le Case del
Popolo della provincia con documenti, libri, foto, oggettistica, poster,
bandiere, volantini, ciclostili e tutte le opere prodotte dall’associazionismo mutualistico
fiorentino. Un’intera documentazione, una miniera preziosa per chi scriverà la
storia di quei decenni.
Ma chi erano i Ciompi a cui è dedicata la
piazza? Erano gli operai salariati che
lavoravano la lana. La produzione e il commercio di tessuti di lusso era alla
base dello sviluppo economico di Firenze che, insieme alle banche, arricchiva
le principali famiglie, il cosiddetto “popolo grasso”. Nel 1378, i Ciompi, che lavoravano in
condizioni per noi oggi impensabili, sfruttati, senza nessuna rappresentanza
politica e sempre precari, si rivoltarono. Le loro saranno le prime insurrezioni popolari a
carattere economico-sociale d’Europa. Una classe di lavoratori salariati contro
i padroni per ottenere miglioramenti economici e normativi e una rappresentanza
politica nel governo cittadino. Nonostante i primi successi dovuti al loro
numero, naturalmente la rivolta finì male e il “popolo grasso” riprese il
potere. Per ottenere i diritti che i Ciompi chiedevano, bisognerà aspettare secoli.