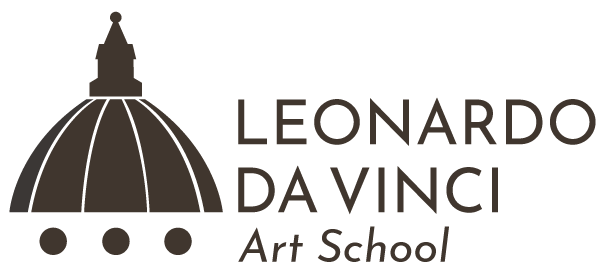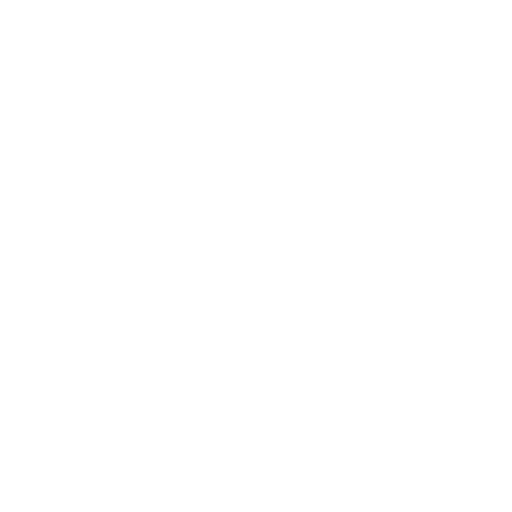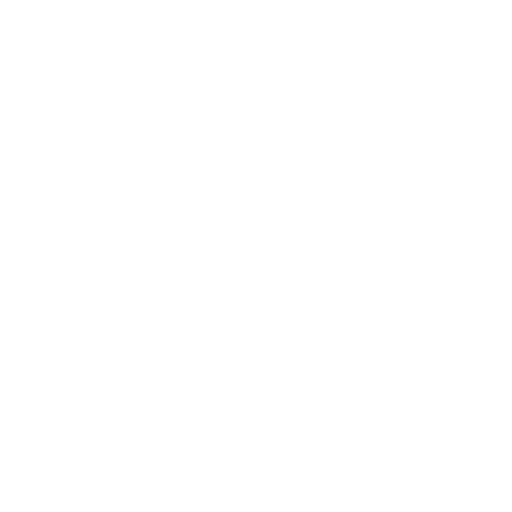Oltre il Rinascimento a Firenze - Il Nuovo Archivio di Stato, una polemica senza fine
I fiorentini sono famosi per essere polemici e non andare mai d’accordo,
fin dai tempi dei Guelfi e dei Ghibellini. Questo lato del carattere cittadino è stato
storicamente molto negativo perché tutte le iniziative finiscono nel nulla tra
discussioni e liti e, se vanno a buon fine, lasciano uno strascico di polemiche
a non finire.
Gli archivi fiorentini sono un patrimonio culturale immenso,
data l’importanza storica della città, ed una di queste dispute, anche se ormai lontana, riguarda proprio il nuovo Archivio di Stato.
Fondato nel 1852 dal Granduca Leopoldo
II di Toscana, l'archivio è “ricco di 600 fondi, per un totale di oltre 75 km di
documenti, dall’VIII secolo ai giorni nostri, delle più diverse tipologie:
carteggi, diplomi, codici miniati, statuti, disegni, carte nautiche e
geografiche che recano iscritta la memoria storica delle vicende politiche,
sociali, culturali e artistiche di Firenze e della Toscana e che fanno
dell’Archivio di Stato di Firenze un punto di riferimento per i ricercatori dei
tutto il mondo” (dal sito ufficiale dell’Archivio di Stato). Oltre a
questi fondi ci sono enormi quantità di materiali amministrativi, economici, catasti,
lasciti, archivi notarili e molto altro.
La sede originaria era nel Palazzo degli Uffizi insieme al museo, e molti materiali erano conservati nei depositi sotterranei e nei piani bassi. Tutti sapevano che l’Arno periodicamente e inevitabilmente inonda la città e con l’alluvione del 1966 i danni furono enormi. Nonostante i precedenti, nessuno ci aveva pensato. Questo non riguardò solo gli Uffizi, anche la Biblioteca Nazionale, una delle più importanti d’Italia, si trova proprio sull’Arno con tutti i suoi depositi sotterranei pieni di libri e documenti. Anche lì fu una catastrofe.
Finalmente negli anni ’80 si decise di trasferire l’Archivio e costruire
una nuova sede, moderna e sicura. Si scelse l'area tra Piazza
Beccaria, viale della Giovane Italia e viale Amendola.
Certo la storia di quel luogo non era di buon auspicio. Fino al 1865 ci passavano
le mura, demolite in quegli anni nel quadro del piano urbanistico
dell’architetto Giuseppe Poggi, legato al progetto "Firenze capitale". Ma il
luogo era lugubre e “maledetto” perché subito fuori Porta alla Croce (ancora oggi
al centro di Piazza Beccaria) dal 1531 al 1759 c’era il Prato della Giustizia,
dove venivano eseguite le condanne capitali dei condannati a morte, tramite
taglio della testa, proprio vicino a dove ora sorge l’Archivio di Stato.
Dopo la demolizione delle mura, nel piano urbanistico del Poggi il terreno
fino all'Arno era destinato a prato pubblico . Invece in una parte venne subito
costruita una caserma per i Carabinieri, ancora esistente. L’altra parte rimase
a prato fino al 1936, quando venne costruita la Casa della Gioventù Italiana
del Littorio (GIL), l’organizzazione fascista dei giovani dai 6 ai 21 anni. La
struttura venne subito chiamata Casa dei Balilla, dal nome dei giovani dagli 8
ai 14 anni inquadrati nell’organizzazione giovanile fascista Opera Nazionale
Balilla, i balilla appunto. Il termine “balilla” era ispirato da un episodio
della rivolta dei genovesi contro l’occupazione austriaca, quando il giovane
Giovan Battista Perasso, detto “balilla”, incitò la folla alla rivolta nel
1746.
Come sempre, i giudizi a riguardo furono molto diversi. Fu definito bellissimo, esaltante, un esempio di
architettura funzionale, ma anche modesto, squallido, un esempio di
monumentalismo di propaganda. In sua lode veniva citata addirittura
un’influenza di Erich Mendelsohn, uno dei più importanti architetti tedeschi,
autore della Torre Einstein di Potsdam, opera-simbolo dell’espressionismo.
Dopo la guerra l’edificio fu usato come piscina, cinema e teatro di varietà
fino al 1975, quando, venne demolito per fare posto all’Archivio di Stato,
costruito dall’architetto Italo Gamberini, la cui opera più citata resta il
Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci a Prato. La decisione venne presa
dalla nuova giunta del Comune di Firenze eletta nel 1975, guidata dal comunista
Elio Gabbuggiani, che non ebbe né dubbi né esitazioni.
Il nuovo edificio dell'Archivio di Stato fu costruito in cemento armato e rivestito di pietra artificiale fatta
di lastre di cemento mescolato a materiali coloranti marroni, con
infissi e altre strutture in ferro scuro. Sicuramente molto efficiente, moderno
e finalmente al sicuro delle alluvioni e degli incendi, ma dall'aspetto pesante, simile a un'istallazione militare, impressione dovuta alle masse di cemento grezzo e alle
strutture in ferro dai colori scuri.
Sul giudizio negativo ha pesato molto l’opinione di Antonio Paolucci, importante
storico dell’arte e a lungo Sovrintendente alle Belle Arti della Provincia di
Firenze, molto amato in città. In un articolo del 2 Febbraio 2001 sul giornale La
Repubblica, Paolucci rimpiange il palazzo “distrutto solo per ragioni
politiche, di puro odio ideologico: perché era fascista e perché era anche
bello. Certo più bello della triste costruzione tirata su in fretta subito dopo
per ospitare l’Archivio di Stato destinato a lasciare gli Uffizi”.
Certo è difficile giudicare se sia giusto mantenere un edificio solo perché
testimonia di una certa epoca e ha una forte identità stilistica. Gli
orientamenti moderni sono impostati a conservare queste strutture, anche
se di gusto e significato lontano da quello contemporaneo.
Se la giunta comunale avesse dovuto prendere la decisione oggi, sicuramente
la Casa del Balilla non sarebbe stata demolita e l’Archivio di Stato sarebbe
stato fatto altrove.

Il lato posteriore dell'Archivio di Stato su Viale Amendola